 C’è una foto che lo ritrae in una strada piena di gente, in centro a Parma, fine anni Quaranta, in abito talare e cappello a larghe tese, il volto giovanile che accenna ad un sorriso, più che un prete sembra un figurino di una casa d’abiti ecclesiastici oppure un attore vestito da prete che stia per salire sul set a interpretare un film di quell’epoca, tra Sordi e Mastroianni, tanto per rendere l’idea. Ed è così che amo ricordarlo: mentre guarda sicuro alla vita col suo sorriso un po’ ironico e un po’ beffardo.
C’è una foto che lo ritrae in una strada piena di gente, in centro a Parma, fine anni Quaranta, in abito talare e cappello a larghe tese, il volto giovanile che accenna ad un sorriso, più che un prete sembra un figurino di una casa d’abiti ecclesiastici oppure un attore vestito da prete che stia per salire sul set a interpretare un film di quell’epoca, tra Sordi e Mastroianni, tanto per rendere l’idea. Ed è così che amo ricordarlo: mentre guarda sicuro alla vita col suo sorriso un po’ ironico e un po’ beffardo.
Monsignor Mario Dellapina è nato a Castellonchio, una frazioncina del Comune di Berceto, il 24 settembre 1913, figlio di Domenico e Margherita Lapina, in una nidiata che sfiorerà i dieci fratelli: la soluzione del seminario, come per molti altri giovanetti dell’epoca, e non solo in montagna, è una questione di sopravvivenza. Ordinato sacerdote il 7 luglio 1937, ha studiato musica a Roma all’Accademia di Santa Cecilia e al Pontificio Istituto Superiore di Musica Sacra, ha proseguito poi a Parma e a Piacenza diplomandosi in canto gregoriano nel 1941, in musica corale nel 1949 e in composizione nel 1953; dal 1955 al 1967 ha insegnato esercitazioni corali al Conservatorio «Arrigo Boito» di Parma; è stato maestro di cappella, guarda-coro della Cattedrale di Parma e insegnante di canto e musica sacra nei seminari di Parma fino al 1967; quindi insegnante di teoria, estetica musicale e paleografia gregoriana presso l’Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano, il Conservatorio di Cagliari, infine quello di Torino, dove scomparve quarant’anni fa, il 4 marzo 1979.
Pastore di anime e maestro di musica, ecco le sue vocazioni che lo hanno fortemente impegnato nella vita. L’attività dominante fu quella di insegnante di musica e compositore di inni sacri ed è qui, attraverso la musica, che la sensibilità di uomo di fede lo faceva in modo rilevante prete.
Oltre la musica, amava i suoi monti e la bellezza della natura che gli richiamava il divino e che cantò con grande finezza espressiva. Si racconta che un giorno d’estate Dellapina, in cammino con un gruppo di seminaristi sul monte Cavallo, trovasse l’ispirazione per il suo Magnificat nell’udire i lontani rintocchi e gli echi delle campane del Santuario della Madonna delle Grazie di Berceto. E poi basta accennare alla suggestiva armonizzazione della Rapsodia montanara – che è stata il biglietto di presentazione, la cover, si può dire oggi, della Corale Collecchiese, per sottolineare questa sua precisa inclinazione culturale prima ancora che musicale.
 Una corale a Collecchio, ora per voci bianche ora per voci virili o miste, è documentata in ambito parrocchiale fin dai primi decenni del Novecento, poi in ambiente laico negli anni Venti e infine ancora all’ombra dei due campanili alla vigilia della guerra quando sia il direttore del coro, il mitico don Guido Anelli, il “prete volante” della Resistenza, e gli stessi coristi incapperanno nella drammatica diaspora bellica.
Una corale a Collecchio, ora per voci bianche ora per voci virili o miste, è documentata in ambito parrocchiale fin dai primi decenni del Novecento, poi in ambiente laico negli anni Venti e infine ancora all’ombra dei due campanili alla vigilia della guerra quando sia il direttore del coro, il mitico don Guido Anelli, il “prete volante” della Resistenza, e gli stessi coristi incapperanno nella drammatica diaspora bellica.
La rifondazione della corale alla metà degli anni Cinquanta può essere definita sotto il profilo storico-semantico come un simbolo della rinascita nel dopoguerra, quando, regolati i conti con la sconfitta dirigenza politica, rimosse le macerie, uomini e donne erano caparbiamente riusciti a rimettere in piedi un paese che come avevano fatto non lo sapevano nemmeno loro, eppure c’erano riusciti.
Era un periodo in cui la pacificazione sociale era ancora da compiere poiché restavano nondimeno aperti seri problemi sindacali, tuttavia le persone che esercitavano allora la leadership nei diversi schieramenti politici rappresentati in Consiglio comunale avevano sufficiente equilibrio per mantenere tranquillo, e in molti casi anche collaborativo, l’ambiente.
Nell’immediato dopoguerra, a causa della difficile situazione economica, si era verificato un certo fenomeno migratorio in particolare verso il Sudamerica, ma già qualcuno cominciava a rientrare. Tra questi ultimi il tenore Ennio Salvarani, che era stato alcuni anni in Cile. In gioventù aveva compiuto studi specifici di canto e avrebbe potuto seguire una brillante carriera se la guerra non ne avesse impedito il proseguimento della preparazione. Rientrato a Collecchio, aveva ripreso contatto con i vecchi compagni del coro ed era naturale che si pensasse ad una ripresa dell’attività coristica. Così ne parlarono col viceparroco don Iginio Ferri che in seminario aveva studiato musica e che in precedenza aveva già fatto qualche tentativo di ricostituire il gruppo se non altro per condecorare le cerimonie liturgiche più solenni con le Messe del Perosi. Da questo gruppo scaturì la decisione di prendere contatto con il maestro don Mario Dellapina.
 Il ricordo più vivo che mi rimane degli anni in cui Dellapina diresse la Corale collecchiese, è legato al concerto alla Sala Bossi di Bologna, il 10 gennaio 1959. È un concorso, anzi, un concorso montanaro che la corale finisce per vincere, ma a me piace considerarlo un concerto, perché quello è l’approccio voluto dal maestro. La Sala Bossi di Bologna è lo scrigno più prestigioso del Conservatorio “Giovanni Battista Martini”, già convento degli Agostiniani. Tappezzata in velluto cremisi, con una piccola pedana per gli strumentisti, ospita concerti e soprattutto concorsi pianistici internazionali. È un auditorium di modeste dimensioni, rettangolare, adatto per musica da camera, non molto idoneo per gruppi corali di alcun genere, meno che mai per cori montanari. Quando, per la Corale, viene il turno di eseguire il proprio repertorio, la Sala Bossi è gremita di appassionati di canti montanari, soci del Club Alpino Italiano e del Centro Turistico Giovanile di Bologna (un’agenzia che si affianca alle attività dell’Azione Cattolica e particolarmente attiva nella Curia del cardinale Lercaro) e soprattutto di amici e parenti dei coristi dei vari complessi in gara.
Il ricordo più vivo che mi rimane degli anni in cui Dellapina diresse la Corale collecchiese, è legato al concerto alla Sala Bossi di Bologna, il 10 gennaio 1959. È un concorso, anzi, un concorso montanaro che la corale finisce per vincere, ma a me piace considerarlo un concerto, perché quello è l’approccio voluto dal maestro. La Sala Bossi di Bologna è lo scrigno più prestigioso del Conservatorio “Giovanni Battista Martini”, già convento degli Agostiniani. Tappezzata in velluto cremisi, con una piccola pedana per gli strumentisti, ospita concerti e soprattutto concorsi pianistici internazionali. È un auditorium di modeste dimensioni, rettangolare, adatto per musica da camera, non molto idoneo per gruppi corali di alcun genere, meno che mai per cori montanari. Quando, per la Corale, viene il turno di eseguire il proprio repertorio, la Sala Bossi è gremita di appassionati di canti montanari, soci del Club Alpino Italiano e del Centro Turistico Giovanile di Bologna (un’agenzia che si affianca alle attività dell’Azione Cattolica e particolarmente attiva nella Curia del cardinale Lercaro) e soprattutto di amici e parenti dei coristi dei vari complessi in gara.
Ogni corale presenta brani obbligati e altri a discrezione, ma per quella di Collecchio è la delicata e raffinata Rapsodia montanara a decidere le sorti del premio. È una giornata memorabile. La Corale Collecchiese capisce ora con che direttore ha a che fare ed ha la consapevolezza di avere assimilato almeno in parte la sua cultura musicale in modo fermo e duraturo, tanto che rimane ancora oggi, quasi come un patrimonio genetico, in entrambi i gruppi corali, la Corale Collecchiese “Mario Dellapina” (erede diretta della vecchia Corale) e il Colliculum Coro (nato nell’ottobre 1989 presso l’Associazione Alpini, che allinea tuttora alcuni ex coristi di Dellapina) e poi dei suoi allievi diventati maestri a loro volta, come Giovanni Veneri e Adolfo Tanzi in particolare.
La data ufficiale di ricostituzione della Corale è indicata nel 29 febbraio 1956, ma al momento il maestro aveva impegni pregressi, per cui le prove iniziarono con un altro prete-musicista, don Giorgio Zilioli, parroco di Madregolo, docente di musica nelle scuole medie, che anche in seguito sarà direttore della Corale e altri complessi come la Verdi.
I mezzi finanziari di cui disponeva la corale erano assolutamente inesistenti, all’inizio. Qualcuno suggerì di accedere ai contributi ministeriali che il Provveditorato poteva erogare qualora si istituisse un Corso di Orientamento Musicale. Detto fatto, si varò la squadra che, a cominciare dall’autunno 1956, per un triennio condurrà la Corale: direttore il maestro Dellapina e insegnanti delle varie sezioni del coro la professoressa Lidia Boni e don Iginio Ferri. Le lezioni si tenevano un paio di volte la settimana in un’aula al piano seminterrato della Casa della Gioventù da poco eretta a fianco dell’antica chiesa romanica. La Boni istruiva i tenori primi e i tenori secondi, don Iginio i baritoni e i bassi. Poi era Dellapina a mettere insieme le quattro voci.
Non ho la competenza per descrivere la sua didattica musicale. Posso dire che non pretendeva una impostazione particolare della bocca e della voce, ma era attento alla modulazione e all’emissione. Curava in modo particolare i piano e i pianissimo: “A cantare forte sono capaci tutti – diceva – ma è con i pianissimi che saltano fuori i difetti e si verifica il reale valore di una corale”. Aveva, il maestro, un senso del suo ruolo e di quello della Corale veramente molto alto, la dignità di fare musica bene dovunque, certo, anche in un piccolo paese come Collecchio. I coristi però non sempre erano allineati al maestro, in questo senso. Forse ci si poteva anche scherzare e riderci sopra e prendersi non troppo sul serio, con la giusta ironia che nella vita è un grande viatico, ma quando si fa musica insieme bisogna farlo con il tono e lo stile dovuti. Un esempio. Talvolta, per stemperare un’atmosfera fin troppo seriosa, saliva una canzonetta falsamente operistica e vagamente di stile verdiano, che cominciava pressappoco così: Oh io vorrei andare sulla Luna in bicicletta, proseguiva con versi alla buona e qui non ripetibili, e si concludeva con un finale trionfante e liberatorio. Di questa canzone popolare c’è anche una versione più ingentilita e meno sboccata, armonizzata da Arturo Benedetti Michelangeli per il Coro SAT di Trento. La versione nostrana era cantata tranquillamente con i coristi anche da don Iginio, con santa innocenza. Ma questo exploit avveniva soltanto se non c’era Dellapina, perché mancava il coraggio di scendere a quelle turcherie lui presente. Chissà, forse le avrebbe tollerate o forse no, e non tanto per la loro esplicita trasgressività, ma in quanto lesive della dignità della musica, una dissacrazione. Forse non è il caso di esagerare, e può essere successo che il maestro lo abbia qualche volta ascoltato, questa specie di jingle da stadio; ma c’era, in ogni caso, nei coristi una sorta di timore reverenziale che li tratteneva dal scendere a eccessive confidenze con un personaggio dotato di una caratura così fortemente carismatica come lui.
Ecco, dunque, come amo ricordare il maestro monsignor Mario Dellapina: con quel certo sorriso sulle labbra, come nella foto sbarazzina di cui dicevo all’inizio, mentre guarda alla vita davanti a sé, tra l’ironico e il beffardo.






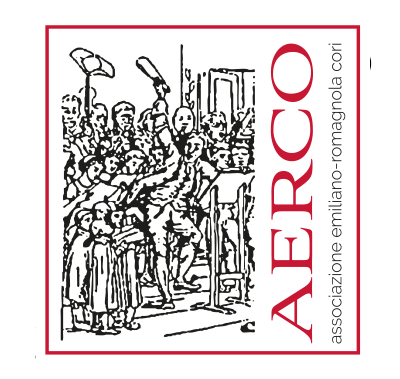


Scrivi un commento