Quella terribile rivoluzione filosofica che condannò il Rinascimento a disperdersi nelle false simmetrie del Barocco ebbe molteplici motivi, tutti riassumibili sotto un’unica formula: nelle parole di Hermann Broch, la “morte del centro e, quindi della luce”. La consapevolezza copernicana di abitare una meteora di materia marginale all’universo, la predicazione di Lutero, col suo scalzare la ragione simbolica della Teologia dalle sue basi, per sostituirvi un drammatico rapporto di incertezza col Divino, dove la colpa a priori dell’umana condizione rende l’arte pietistico ritorno alle radici infantili – e dunque völkisch, “popolari” – infine, la lotta tra potere politico ed ecclesiastico, che induce l’architettura civile a rivaleggiare in falsi fondali e prospettive in fuga con quella religiosa, fino ad allora giustapposta ai Palazzi Comunali in quella perfetta armonia nella divisione simbolica degli spazi che dava alle piazze delle città ideali – si pensi a Pienza – rinascimentali il fascino di un accordo tra uomo e divinità: da tutte queste intime tragedie dello stile si origina l’involuzione convulsa del Manierismo, fiorita di volute e trompe-l’oeil in cui la coscienza intraprende la ricerca della luce, del senso, destinata poi a solidificarsi, nel Barocco, in una razionalizzazione del disordine strutturata secondo un’unica regola: distinguere, catalogare e quindi stilizzare ogni umano “affetto”: esasperare la soggettività del sentimento, fino a rendere espressione ciò che prima non era che armonia di struttura, ponte tra tempo e spazio, tra simbolo e fuggevole sensazione.
Ciò che lega le facciate curvilinee, quasi evaporanti in un’aria malsana di afa, del Borromini – un’aria come doveva essere quella della notte romana in cui l’architetto si gettò sulla propria spada, incaricando poi il servo del colpo di grazia – la “seconda pratica” di Monteverdi, per la prima volta sollevata ai vertici del gusto nel Combattimento di Tancredi e Clorinda, ed infine lo spazio vuoto, la cupola nera del Caravaggio: tutto questo, è proprio il senso di angosciosa attesa dell’Ignoto, il manifestarsi profetico del mana divino, di cui l’artista si fa aruspice primitivo. Se, dunque, nel Rinascimento gli artisti dovevano essere anche teologi, nel Barocco il trionfo dell’introspezione, della grammatica delle passioni unisce tutte le arti in uno stile di transizione il cui fascino maggiore è quella ossessione del vuoto, quella paura dello spazio materiale che negli spiriti più elevati si fa metafora della colpa originaria, e quindi della morte. Nel Barocco la morte non è solo il passaggio buio che attende l’uomo alla foce del tempo, ma è anche quel salto nella luce con cui inizia la sua momentanea avventura terrena: essa sta ai due estremi della corda tesa sull’abisso esistenziale. Ecco dunque il motivo delle false prospettive barocche: inventare chiese dentro chiese, vite dentro vite; ecco il motivo della prevalenza, in poesia, della metafora – che è corpo e soffio – sul simbolo, che è trascendente fissità. Così Ciro di Pers, allievo del Marino, pubblica un sonetto dedicato ad un grande orologio meccanico – ossessione, questa, dell’epoca – in cui già si intravede quella riduzione dell’uomo a congegno di molle, fantoccio creato dal Tempo per suo divertimento, così caro al romantico musico-poeta Hoffmann, ed insieme alla tradizione chassidica degli Ebrei, col loro mito del Golem, destinato a sfociare poi, in un dramma di Capek, nel moderno robot.
A questo sconvolgente passaggio dell’uomo da centro dell’universo, qual era in Pico della Mirandola, a scheggia impazzita del tempo, la musica reagisce detronizzando il contrappunto – il luogo della coincidenza degli opposti – per esaltare l’armonia: questo microcosmo della forma in cui la perpetua improvvisazione degli abbellimenti (anch’essi segno di una coazione a riempire lo spazio) e la pulsazione del basso continuo – con il suo orbitare dentro a formule per cui la ragione individuale cerca di arginare la follia del non-senso cosmico – si fa, anche qui per metafora, psicologia dell’animo umano.
La nostra abitudine a riconoscere nella musica l’arte espressiva per eccellenza ci impedisce di sentire sulla nostra pelle quel senso di disagio e insieme di affascinata rivoluzione dei sensi che avvolse come una pioggia di lapilli infuocati il pubblico riunito, quella sera di Carnevale del 1624, in Palazzo Mocenigo, quando Monteverdi distillò nel glorioso genere del Mottetto tutti i veleni propri all’ancor giovane Diciassettesimo secolo: il secolo del complesso paterno, in cui le ancora vive libertà nazionali vengono sacrificate sull’altare dell’assolutismo, come a quel potere che, unico, può salvare dal senso di colpa – la Riforma è una lotta fratricida tra Cristiani; un insulto a Dio, di cui oscura il Dogma – e dal conseguente collasso dell’Io.
Il Combattimento di Tancredi e Clorinda è l’alba della passione. Monteverdi, che ne era ben consapevole, ritenne quindi opportuno ricorrere all’artificio di una lettera al Mocenigo, per preparare gli ascoltatori a quella destrutturazione traumatica di ogni convenzionale sintassi. “Sapendo che gli contrarij affetti sono quelli che grandemente muovono l’animo nostro, fine del movere che deve avere la bona musica (…) diedi di piglio al divino Tasso, come poeta che esprime con ogni proprietà e naturalezza con la sua oratione quelle passioni che tende a voler descrivere”: così Monteverdi, in un passaggio di una sapienza retorica davvero barocca, dove si afferma, quasi distrattamente, che la musica è un’“arte del movere” – e quindi dramma – ornata di ogni “oratione”, di ogni tecnica della persuasione, secondo un’idea dell’accordo di suoni come gerarchia dei luoghi “topici”occulti nell’animo umano che porterà Marpurg a catalogare gli stili musicali in base alle articolazioni dell’orazione classica definiti da Quintiliano: inventio, dispositio, elocutio, narratio…

La Voix Humaine: Il Combattimento di Tancredi e Clorinda
Ma la grande intuizione di Monteverdi sta in quella litote dell’“oratione espressa con naturalezza”: uno scontro di significati, come si vede, alla cui base c’è la stessa dinamica che porta il Bernini, nella Fontana del Tritone, a fare della coda di un delfino una serto rampicante su cui l’acqua costruisce ponti d’arcobaleno. È il trionfo di quello che il compositore stesso chiama “il concitato genere”: il tactus ritmico racconta l’aritmia del cuore, in contrapposizione dinamica col melos patetico; a questa opposizione costruttiva, nell’architettura sacra barocca, corrisponde l’invenzione dello spazio vuoto, a perdita d’occhio, in cui l’irruzione del transetto nella continuità delle cappelle laterali forza lo spazio all’impossibile armonia di buio e luce radente. Le finestre piovono luce fissa su punti asimmetrici, secondo l’imperscrutabile logica dell’irradiazione divina, ed a questi luoghi del miracolo si oppongono le tenebre dell’inconscio, che fanno sì ogni svolta celi un incubo: ogni simbolo sacro, impregnato d’ansia, sveli, nell’illusione dei sensi, la presenza del suo correlato demoniaco. È l’ambiguità del segno: la Santa Teresa del Bernini, sospesa tra estasi mistica e sensuale perdizione, raggruppa in sé ogni prospettiva luminosa; isola nel tempo un singolo istante di gloria così come, nel Combattimento, Monteverdi sospende il “pirrichio scalpitante” del ritmo nella radiante conversione finale della guerriera saracena, un momento in cui il “picciol rivo” del testo diventa fiume di grazia, e la simbiosi tra arte e natura si fa – qui per la prima volta – opera d’arte totale.
In una prospettiva opposta – e quindi, baroccamente, analoga – Caravaggio lavora sulle scansioni del buio in cui l’architettura della Controriforma precipita le cappelle laterali, isolando nella luce la rivelazione del vero. In San Matteo e l’angelo, il pittore mette in scena un vecchio saggio mentre, nell’atto di scrivere, viene sorpreso da un fruscio alle sue spalle: è l’angelo di luce, colpito sulla fronte dal quale il filosofo decifrator di segni si confessa impotente di fronte alla momentanea verità del miracolo. “Ahi vista, ahi conoscenza!”: dice Tancredi allo svelarsi dell’amata Clorinda, che lui stesso ha ucciso, in un luogo in cui Monteverdi, architetto dell’anima, rapprende nell’icona dell’ornamento il fluire, fino ad allora sfrenato, dell’azione. Siamo nel cuore di un teatro che non è – come poi sarà nel trionfo dell’Opera – semplice messa in scena, ma itinerario nell’“uomo interiore” di Sant’Agostino, per cui la mente è specchio in cui si riflette, per oscuri enigmi, la Creazione, e spazio e tempo si fondono in un unico, irripetibile spazio espressivo.
La “seconda pratica” di Monteverdi, quindi, è ben più che una rivoluzione stilistica: è il trionfo del mare della soggettività contro i pilastri del rinascimentale mondo dei simboli. Ma quella visionaria lettera in cui Monteverdi, con quell’arte di alludere con noncuranza che ne fa un importante scrittore, racconta il suo Combattimento, cela un altro luogo di potente suggestione, allorché afferma di aver resuscitato quel “concitato genere” tanto caro a Platone, e non più praticato dai moderni per mancanza di opportune capacità declamatorie. Il parallelo qui istituito tra il pulpito delle chiese barocche – vera tribuna per esercizi nello stile patetico – e la scena del teatro greco, in cui l’eroe tragico si staglia nella nudità della sua maschera, ha del prodigioso. Dopo il dialogo del contrappunto, insomma, la musica armonica non può che praticare le aspre secche del monologo. Ogni uomo è un’isola, nonostante il poeta John Donne cerchi, in questi stessi anni, di affermare pateticamente il contrario.
Strana antinomia, quella del Combattimento, per un giorno di Carnevale; non fosse che i macchinari scenici, i meravigliosi artifici delle Feste Rinascimentali cui, in un Rinascimento che faceva dell’architettura l’epicentro di tutte le arti, misero mano Leonardo e Michelangelo, svelano, in quella sera del 1624, per la prima volta la loro vera natura: sono epifanie del mondo alla rovescia, il mondo carnevalesco sotto la cui giocosità s’annida il dramma della perdita, la manca di senso onde la musica, da allora, comincia a regredire alla grammatica delle pulsioni, al “pirrichio di concitate movenze” monteverdiano dal quale, nei secoli a venire, non si è più redenta.
L’unico possibile risolversi da questo infernale sposalizio di estasi e sensi è l’invenzione di un nuovo genere; ma non sarà certo Venezia, che della perdita del Sacro ha fatto il presupposto della propria potenza economica, a realizzare questa sintesi. Mentre dunque la Repubblica del Leone assiste, nei suoi cinquanta teatri, al trionfo dell’Opera, a Roma i devoti di un santo irregolare, Filippo Neri, si ingegnano ad inventare una nuova forma di teatro dell’anima; però, piuttosto che elaborare una poetica, inventano uno spazio architettonico strategico: l’Oratorio, facendo dei suoi limiti – il maggiore dei quali è l’aver rinunciato all’alleanza tra arte e natura – altrettanti punti di forza. È dunque all’interno di piccole chiese: S. Girolamo della Carità, Santa Maria dell’Orazione e Morte, Santa Maria della Rotonda – i cui nomi, oltretutto, definiscono una grammatica ideale della Pietà barocca – e nei limiti di una cerimonia dimessa e contrita come l’Ufficio di Quaresima, che si prepara il superamento dell’angoscioso dualismo tra sensi e spirito cui dobbiamo l’eccentrica, correlata genialità di un Monteverdi e di un Borromini: antinomia del Barocco, questa, che l’estrema povertà dei mezzi dovesse diventare nuovo rigoglio della languente intimità devota. Sono, anche questi, i giochi della luce crepuscolare: della luce morente…






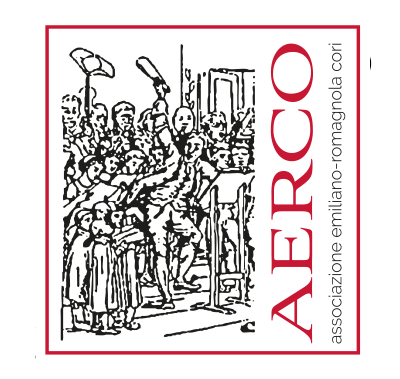


Scrivi un commento