L’archeologo e antropologo britannico Steven Mithen, in un testo del 2005 (Il canto degli antenati, ed. it. 2007), dapprima chiarisce, analizzando una serie di casi clinici (musicisti che hanno perso l’uso della parola e conservato quella della musica e viceversa) che il linguaggio e la musica sono indipendenti e vengono in parte guidate da aree diverse del nostro cervello; successivamente, esaminando i reperti dell’uomo di Neanderthal, dove le cavità ossee contenenti gli organi della fonazione appaiono poco sviluppate mentre lo è ampiamente quella del cranio destinata all’area del cervello dedita alla musica, trae una conclusione sorprendente: il nostro antenato di Neanderthal non conosceva la parola, ma sapeva cantare. Dotato di orecchio assoluto, era in grado di distinguere l’altezza dei suoni emessi e attribuire ad essi diversi significati. Le possibilità di comunicazione, rispetto a un linguaggio verbale, erano ovviamente limitate: e anche per questo il sapiens prese il sopravvento sull’uomo di Neanderthal. Ma questa teoria non può che affascinare noi, che dal canto traiamo emozioni e al canto dedichiamo tante energie. La musica come linguaggio più antico della parola. Non sono pochi i miti in cui la divinità crea il mondo dal suono: e anche nel Primo Testamento, si tratti di suscitare lo spirito dei profeti o di calmare Saul riportandolo a un rapporto equilibrato con Dio, la musica è un ponte verso il divino, ma anche un mezzo per arrivare alla profondità dell’uomo: il luogo, si potrebbe dire, dove l’umano e il divino s’incontrano e si fondono. Ciascuno di noi ripercorre il cammino dell’umanità: il bambino, secondo Mithen, nasce dotato di orecchio assoluto, che perde poi nei primi mesi, per passare all’apprendimento della lingua. Il canto, insomma, ci conduce alla radice della nostra natura umana. E questo distaccarsi dal canto, che mentre viene intensamente coltivato da una minoranza appare abbandonato dai più, ci interroga su cosa sia oggi l’uomo e l’idea che ne abbiamo. Se ne è accennato, in qualche intervento, anche durante il convegno del 50°. Cantare non fa più parte delle abitudini e delle competenze dell’uomo medio. Questo rende da un lato più problematico il quotidiano della nostra coralità amatoriale, che non trova più già ‘pronto’, il corista, ma lo deve formare dalla base: come se a scuola di calcio si dovesse incominciare dall’insegnare a correre. Ma dall’altro rende ancor più prezioso il nostro ruolo: non facciamo solo musica, ma preserviamo e rendiamo disponibile a tutti un elemento importante, fondamentale, della nostra umanità. In un momento che tutti percepiamo come critico della nostra storia, il cantare affonda le radici negli strati più arcaici della nostra vicenda e ci aiuta a scrutare e costruire il futuro.
Editoriale Farcoro n.03 2021
Scritto da: Sandro Bergamo
Dirige La Cappella Altoliventina fin dalla sua fondazione. Diplomato in clarinetto e in canto, ha diretto diverse formazioni corali (Campiello di Meduna di Livenza, Jacopo Tomadini di San Vito al Tagliamento) e dirige tuttora il gruppo vocale Dumblis e Puemas di Udine. Ha registrato, come cantante e direttore, diversi CD. Giornalista pubblicista, è stato redattore della rivista Choralia dal 1995 al 2017, è stato direttore di Choraliter, quadrimestrale della Feniarco, dal 1999 al 2016.
Dal 1994 al 1999 è stato membro della commissione diocesana di musica sacra e presidente della commissione artistica provinciale dell'USCI di Pordenone.






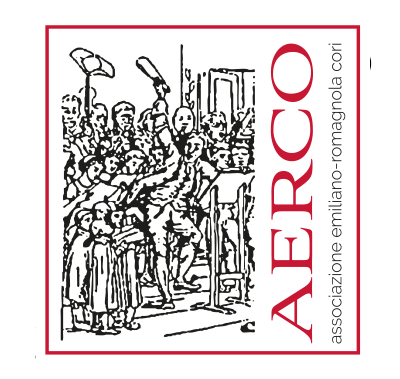


Scrivi un commento