A vent’anni dalla scomparsa l’immagine di Benedetti Michelangeli appare ancora avvolta da quell’alone che ha isolato la personalità del grande interprete entro una sfera quasi inattingibile, un mito affidato solo alle suggestioni di testimonianze discografiche (che lui considerava con sospetto) e che ha finito per celare il profilo più autentico dell’uomo. Lasciando in ombra quegli aspetti che costituivano parte integrante della sua arte, come la ricerca di un rapporto più diretto con la natura quale dimensione dello spirito, quel suo appartarsi che non era, infatti, un fuggire dal mondo, come si é voluto spesso leggere quella sua riservatezza, talora al limite della scontrosità, ma al contrario un modo per conoscere meglio il mondo, riflesso nella stessa essenza della musica. Fin dall’inizio di quella sua carriera così prodigiosa possiamo riconoscere, nel ripercorrerne con la memoria l’intero arco di oltre mezzo secolo, il segno costante di questo suo tendere ad una rivelazione di ciò che la musica racchiude e che sembra ogni volta svanire nel nulla, se non fosse la magia della forma a trattenerne la memoria, come ci invitano a riflettere i versi di Gottfried Benn: la forma, il gesto della forma che si diede, ci demmo – é vero, tu sei terra ma la terra devi scavarla. E Benedetti Michelangeli la terra la scavò, con dedizione eroica, come se ogni esito raggiunto non fosse che un precedente al passo successivo. Uno scavo che muoveva dunque da una visione dell’insieme intesa come essenzialità, come rifiuto anche di tutto ciò che non appartenesse a tale ordine di necessità intrinseca. Ecco allora la scelta di vita, la semplicità come tramite per ricreare con animo terso quel piccolo frammento del mondo che é racchiuso entro il vibrare della forma musicale, la forma fatta di suono, di materia che si fa suono, da cui l’impossessarsi dello strumento come passaggio obbligato, tramite strenuamente necessario. Perché se tale obiettivo trovava la prima radice nelle doti straordinarie che madre natura gli aveva dato, quella sua stupefacente precocità, quelle doti pianistiche miracolose, è altrettanto vero come dietro tale dotazione naturale operasse l’idea di servizio, appunto. Che era artigianalità, controllo assiduo, pazienza, scavo inesausto, lavoro, una parola questa che Michelangeli prediligeva: non parlava mai di studio, ma di lavoro. E proprio su questa tensione continua, la stessa che Michelangeli chiedeva ai suoi allievi verso i quali dedicava non minore impegno, credo si sia creato, in modo non poco equivoco, il mito della “perfezione”, che è diventato il termine tuttofare in cui racchiudere l’immagine del nostro interprete. Un termine che Michelangeli peraltro ha sempre respinto: ” Non so cosa voglia dire, é una parola che non ho mai capito: per me perfezione significa limitazione. L’evoluzione é un’altra cosa”. Termine ambivalente anche, perché insieme all’assolutezza del dominio tecnico della tastiera si celava in esso un senso del limite cui, infatti, il velo della perfezione faceva da mascheramento. In altre parole si riteneva che una volta toccata la perfezione Michelangeli rimanesse sempre uguale, ripetitore di se stesso; impressione alimentata dalla minor visibilità dell’ultimo periodo. In effetti Michelangeli negli ultimi anni, e non solo per motivi legati alla sua salute, aveva ridotto le occasioni pubbliche. Era un segno ulteriore della tensione riflessiva che lo sospingeva a scavare sempre più a fondo entro ad ogni opera; e nel contempo un segnale indubbio di un progressivo distacco, come una vera e propria dissociazione, da un mondo che sembrava ormai rispondere a ragioni più vicine a quelle degli affari, del commercio, che non a quelle della musica: la quale é invece un’arte lenta, che richiede pazienza, assiduità, riflessione. Come il lavoro di Michelangeli, appunto, che nasceva, in una simbiosi unica, dal testo musicale e dallo strumento. Con esiti sempre sorprendenti, come avveniva ad ogni nuova occasione d’incontro col pubblico, dove l’approdo precedente, pur stampato nella memoria con la forza ineludibile delle grandi interpretazioni, serviva a dar la misura delle nuove conquista. Mi è difficile dimenticare quell’ultima Sonata di Beethoven, ascoltata, a Bregenz e ancora a Londra agli inizi degli anni ’90, che aveva assunto un’evidenza drammatica impressionante: dove l’interprete sottolineava le dissonanze con un’incisività dilaniante, come pure scatenava i contrasti ritmici, gli accenti, gli sforzati come mai si sarebbe
racchiuso entro il vibrare della forma musicale, la forma fatta di suono, di materia che si fa suono, da cui l’impossessarsi dello strumento come passaggio obbligato, tramite strenuamente necessario. Perché se tale obiettivo trovava la prima radice nelle doti straordinarie che madre natura gli aveva dato, quella sua stupefacente precocità, quelle doti pianistiche miracolose, è altrettanto vero come dietro tale dotazione naturale operasse l’idea di servizio, appunto. Che era artigianalità, controllo assiduo, pazienza, scavo inesausto, lavoro, una parola questa che Michelangeli prediligeva: non parlava mai di studio, ma di lavoro. E proprio su questa tensione continua, la stessa che Michelangeli chiedeva ai suoi allievi verso i quali dedicava non minore impegno, credo si sia creato, in modo non poco equivoco, il mito della “perfezione”, che è diventato il termine tuttofare in cui racchiudere l’immagine del nostro interprete. Un termine che Michelangeli peraltro ha sempre respinto: ” Non so cosa voglia dire, é una parola che non ho mai capito: per me perfezione significa limitazione. L’evoluzione é un’altra cosa”. Termine ambivalente anche, perché insieme all’assolutezza del dominio tecnico della tastiera si celava in esso un senso del limite cui, infatti, il velo della perfezione faceva da mascheramento. In altre parole si riteneva che una volta toccata la perfezione Michelangeli rimanesse sempre uguale, ripetitore di se stesso; impressione alimentata dalla minor visibilità dell’ultimo periodo. In effetti Michelangeli negli ultimi anni, e non solo per motivi legati alla sua salute, aveva ridotto le occasioni pubbliche. Era un segno ulteriore della tensione riflessiva che lo sospingeva a scavare sempre più a fondo entro ad ogni opera; e nel contempo un segnale indubbio di un progressivo distacco, come una vera e propria dissociazione, da un mondo che sembrava ormai rispondere a ragioni più vicine a quelle degli affari, del commercio, che non a quelle della musica: la quale é invece un’arte lenta, che richiede pazienza, assiduità, riflessione. Come il lavoro di Michelangeli, appunto, che nasceva, in una simbiosi unica, dal testo musicale e dallo strumento. Con esiti sempre sorprendenti, come avveniva ad ogni nuova occasione d’incontro col pubblico, dove l’approdo precedente, pur stampato nella memoria con la forza ineludibile delle grandi interpretazioni, serviva a dar la misura delle nuove conquista. Mi è difficile dimenticare quell’ultima Sonata di Beethoven, ascoltata, a Bregenz e ancora a Londra agli inizi degli anni ’90, che aveva assunto un’evidenza drammatica impressionante: dove l’interprete sottolineava le dissonanze con un’incisività dilaniante, come pure scatenava i contrasti ritmici, gli accenti, gli sforzati come mai si sarebbe  potuto immaginare. Una sequenza di sorprese, dunque, gli ultimi concerti, fino a quello estremo, la serata di Amburgo del 7 maggio 1993, programma interamente debussyano, addirittura inquietante, per la vividezza che andava sprigionandosi da ogni Prélude, da ognuna delle Images , la ricchezza vitale che andava liberandosi da quella lingua spesso enigmatica, che la forma lascia appena intuire. Una forma che la visione di quell’ultimo Michelangeli rendeva flessibile e pur sempre essenziale; una forma legata ad un melos sotteraneo, virtuale molto spesso, in quanto affidato soltanto a poche note, e che tuttavia sprigionava tutto il suo respiro infinito. Un melos incantato e disincantato insieme, con quei rapinosi slanci subito sedati e richiamati entro un più assorto contemplare. La vita, appunto, che faceva irruzione attraverso l’ammicco ironico, pudicamente poi riassorbito nell’arabesco, lo scatto quasi gestuale che si fa graffito sonoro per poi perdersi nello spazio indefinito, per scomparire in quei silenzi che l’ultimo Michelangeli aveva scavato come attoniti interrogativi; e pur sempre segmenti di una forma ideale. Per dire quanto lavoro, quanta vita fosse passata dal puro cristallo degli esordi; da lasciar ancora pensare a quali altri approdi, se il discorso non si fosse arrestato dopo quella stregata serata amburghese.
potuto immaginare. Una sequenza di sorprese, dunque, gli ultimi concerti, fino a quello estremo, la serata di Amburgo del 7 maggio 1993, programma interamente debussyano, addirittura inquietante, per la vividezza che andava sprigionandosi da ogni Prélude, da ognuna delle Images , la ricchezza vitale che andava liberandosi da quella lingua spesso enigmatica, che la forma lascia appena intuire. Una forma che la visione di quell’ultimo Michelangeli rendeva flessibile e pur sempre essenziale; una forma legata ad un melos sotteraneo, virtuale molto spesso, in quanto affidato soltanto a poche note, e che tuttavia sprigionava tutto il suo respiro infinito. Un melos incantato e disincantato insieme, con quei rapinosi slanci subito sedati e richiamati entro un più assorto contemplare. La vita, appunto, che faceva irruzione attraverso l’ammicco ironico, pudicamente poi riassorbito nell’arabesco, lo scatto quasi gestuale che si fa graffito sonoro per poi perdersi nello spazio indefinito, per scomparire in quei silenzi che l’ultimo Michelangeli aveva scavato come attoniti interrogativi; e pur sempre segmenti di una forma ideale. Per dire quanto lavoro, quanta vita fosse passata dal puro cristallo degli esordi; da lasciar ancora pensare a quali altri approdi, se il discorso non si fosse arrestato dopo quella stregata serata amburghese.





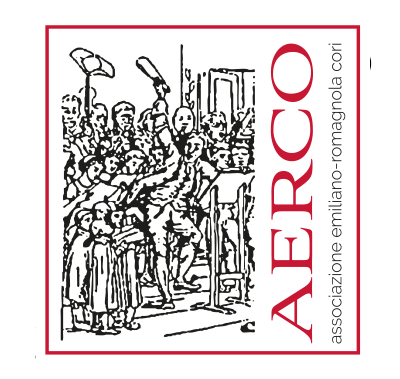


Scrivi un commento